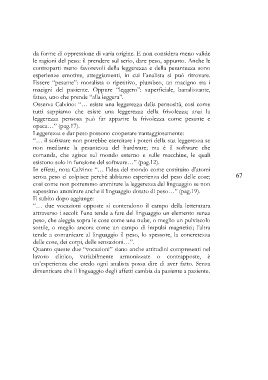Page 63 - Il vaso di Pandora XXII n.2 2014
P. 63
forme di oppressione di varia origine. E non considera meno valide 67
le ragioni del peso: il prendere sul serio, dare peso, appunto. Anche le
controparti meno favorevoli della leggerezza e della pesantezza sono
esperienze emotive, atteggiamenti, in cui l’analista si può ritrovare.
Essere “pesante’’: moralista o ripetitivo, plumbeo, un macigno tra i
macigni del paziente. Oppure “leggero’’: superficiale, banalizzante,
fatuo, uno che prende “alla leggera’’.
Osserva Calvino: “… esiste una leggerezza della pensosità, così come
tutti sappiamo che esiste una leggerezza della frivolezza; anzi la
leggerezza pensosa può far apparire la frivolezza come pesante e
opaca…” (pag.17).
Leggerezza e dar peso possono cooperare vantaggiosamente:
“… il software non potrebbe esercitare i poteri della sua leggerezza se
non mediante la pesantezza del hardware; ma è il software che
comanda, che agisce sul mondo esterno e sulle macchine, le quali
esistono solo in funzione del software…” (pag.12).
In effetti, nota Calvino: “… l’idea del mondo come costituito d’atomi
senza peso ci colpisce perché abbiamo esperienza del peso delle cose;
così come non potremmo ammirare la leggerezza del linguaggio se non
sapessimo ammirare anche il linguaggio dotato di peso…’’ (pag.19).
E subito dopo aggiunge:
“… due vocazioni opposte si contendono il campo della letteratura
attraverso i secoli: l’una tende a fare del linguaggio un elemento senza
peso, che aleggia sopra le cose come una nube, o meglio un pulviscolo
sottile, o meglio ancora come un campo di impulsi magnetici; l’altra
tende a comunicare al linguaggio il peso, lo spessore, la concretezza
delle cose, dei corpi, delle sensazioni…”.
Quanto queste due “vocazioni” siano anche attitudini compresenti nel
lavoro clinico, variabilmente armonizzate o contrapposte, è
un’esperienza che credo ogni analista possa dire di aver fatto. Senza
dimenticare che il linguaggio degli affetti cambia da paziente a paziente.
le ragioni del peso: il prendere sul serio, dare peso, appunto. Anche le
controparti meno favorevoli della leggerezza e della pesantezza sono
esperienze emotive, atteggiamenti, in cui l’analista si può ritrovare.
Essere “pesante’’: moralista o ripetitivo, plumbeo, un macigno tra i
macigni del paziente. Oppure “leggero’’: superficiale, banalizzante,
fatuo, uno che prende “alla leggera’’.
Osserva Calvino: “… esiste una leggerezza della pensosità, così come
tutti sappiamo che esiste una leggerezza della frivolezza; anzi la
leggerezza pensosa può far apparire la frivolezza come pesante e
opaca…” (pag.17).
Leggerezza e dar peso possono cooperare vantaggiosamente:
“… il software non potrebbe esercitare i poteri della sua leggerezza se
non mediante la pesantezza del hardware; ma è il software che
comanda, che agisce sul mondo esterno e sulle macchine, le quali
esistono solo in funzione del software…” (pag.12).
In effetti, nota Calvino: “… l’idea del mondo come costituito d’atomi
senza peso ci colpisce perché abbiamo esperienza del peso delle cose;
così come non potremmo ammirare la leggerezza del linguaggio se non
sapessimo ammirare anche il linguaggio dotato di peso…’’ (pag.19).
E subito dopo aggiunge:
“… due vocazioni opposte si contendono il campo della letteratura
attraverso i secoli: l’una tende a fare del linguaggio un elemento senza
peso, che aleggia sopra le cose come una nube, o meglio un pulviscolo
sottile, o meglio ancora come un campo di impulsi magnetici; l’altra
tende a comunicare al linguaggio il peso, lo spessore, la concretezza
delle cose, dei corpi, delle sensazioni…”.
Quanto queste due “vocazioni” siano anche attitudini compresenti nel
lavoro clinico, variabilmente armonizzate o contrapposte, è
un’esperienza che credo ogni analista possa dire di aver fatto. Senza
dimenticare che il linguaggio degli affetti cambia da paziente a paziente.