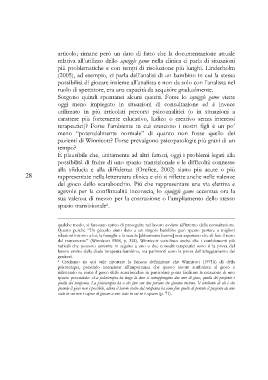Page 26 - Il vaso di Pandora XXII n.2 2014
P. 26
articolo; rimane però un dato di fatto che la documentazione attuale
relativa all’utilizzo dello squiggle game nella clinica ci parla di situazioni
più problematiche e con tempi di risoluzione più lunghi. Linderholm
(2005), ad esempio, ci parla dell’analisi di un bambino in cui la stessa
possibilità di giocare insieme all’analista e non da solo con l’analista nel
ruolo di spettatore, era una capacità da acquisire gradualmente.
Sorgono quindi spontanei alcuni quesiti. Forse lo squiggle game viene
oggi meno impiegato in situazioni di consultazione ed è invece
utilizzato in più articolati percorsi psicoanalitici (o in situazioni a
carattere più fortemente educativo, ludico o creativo senza interessi
terapeutici)? Forse l’ambiente in cui crescono i nostri figli è un po’
meno “potenzialmente normale” di quanto non fosse quello dei
pazienti di Winnicott? Forse prevalgono psicopatologie più gravi di un
tempo?
È plausibile che, unitamente ad altri fattori, oggi i problemi legati alla
possibilità di fruire di uno spazio transizionale e le difficoltà connesse
alla sfiducia e alla diffidenza (Orefice, 2002) siano più acute o più
28 rappresentate nella letteratura clinica e ciò si riflette anche nelle valenze
del gioco dello scarabocchio. Più che rappresentare una via elettiva e
agevole per la conflittualità inconscia, lo squiggle game accentua ora la
sua valenza di mezzo per la costruzione o l’ampliamento dello stesso
spazio transizionale6.
qualche modo, si facevano carico di proseguire nel lavoro avviato all’interno della consultazione.
Questo perché “Un piccolo aiuto dato a un singolo bambino può spesso portare a migliori
relazioni intorno a lui; la famiglia e la scuola [abbastanza buone] non aspettano che di fare il resto
del trattamento” (Winnicott 1968, p. 324). Winnicott sottolinea anche che i cambiamenti più
radicali che possono avvenire in seguito a uno o due consulti terapeutici sono sì la prova del
lavoro svolto dalla diade terapeuta-bambino, ma parimenti sono la prova dell’atteggiamento dei
genitori.
6 Crediamo sia qui utile riportare la famosa definizione che Winnicott (1971b) dà della
psicoterapia, ponendo attenzione all’importanza che questo autore attribuisce al gioco e
riflettendo su come il gioco dello scarabocchio in particolare possa facilitare la creazione di uno
spazio potenziale: «La psicoterapia ha luogo là dove si sovrappongono due aree di gioco, quella del paziente e
quella del terapeuta. La psicoterapia ha a che fare con due persone che giocano insieme. Il corollario di ciò è che
quando il gioco non è possibile, allora il lavoro svolto dal terapeuta ha come fine quello di portare il paziente da uno
stato in cui non è capace di giocare a uno stato in cui ne è capace» (p. 71).
relativa all’utilizzo dello squiggle game nella clinica ci parla di situazioni
più problematiche e con tempi di risoluzione più lunghi. Linderholm
(2005), ad esempio, ci parla dell’analisi di un bambino in cui la stessa
possibilità di giocare insieme all’analista e non da solo con l’analista nel
ruolo di spettatore, era una capacità da acquisire gradualmente.
Sorgono quindi spontanei alcuni quesiti. Forse lo squiggle game viene
oggi meno impiegato in situazioni di consultazione ed è invece
utilizzato in più articolati percorsi psicoanalitici (o in situazioni a
carattere più fortemente educativo, ludico o creativo senza interessi
terapeutici)? Forse l’ambiente in cui crescono i nostri figli è un po’
meno “potenzialmente normale” di quanto non fosse quello dei
pazienti di Winnicott? Forse prevalgono psicopatologie più gravi di un
tempo?
È plausibile che, unitamente ad altri fattori, oggi i problemi legati alla
possibilità di fruire di uno spazio transizionale e le difficoltà connesse
alla sfiducia e alla diffidenza (Orefice, 2002) siano più acute o più
28 rappresentate nella letteratura clinica e ciò si riflette anche nelle valenze
del gioco dello scarabocchio. Più che rappresentare una via elettiva e
agevole per la conflittualità inconscia, lo squiggle game accentua ora la
sua valenza di mezzo per la costruzione o l’ampliamento dello stesso
spazio transizionale6.
qualche modo, si facevano carico di proseguire nel lavoro avviato all’interno della consultazione.
Questo perché “Un piccolo aiuto dato a un singolo bambino può spesso portare a migliori
relazioni intorno a lui; la famiglia e la scuola [abbastanza buone] non aspettano che di fare il resto
del trattamento” (Winnicott 1968, p. 324). Winnicott sottolinea anche che i cambiamenti più
radicali che possono avvenire in seguito a uno o due consulti terapeutici sono sì la prova del
lavoro svolto dalla diade terapeuta-bambino, ma parimenti sono la prova dell’atteggiamento dei
genitori.
6 Crediamo sia qui utile riportare la famosa definizione che Winnicott (1971b) dà della
psicoterapia, ponendo attenzione all’importanza che questo autore attribuisce al gioco e
riflettendo su come il gioco dello scarabocchio in particolare possa facilitare la creazione di uno
spazio potenziale: «La psicoterapia ha luogo là dove si sovrappongono due aree di gioco, quella del paziente e
quella del terapeuta. La psicoterapia ha a che fare con due persone che giocano insieme. Il corollario di ciò è che
quando il gioco non è possibile, allora il lavoro svolto dal terapeuta ha come fine quello di portare il paziente da uno
stato in cui non è capace di giocare a uno stato in cui ne è capace» (p. 71).