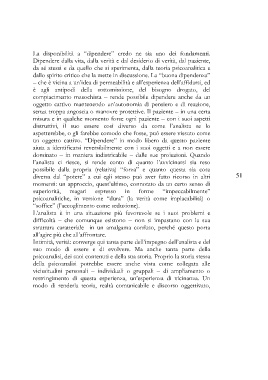Page 47 - Il vaso di Pandora XXII n.2 2014
P. 47
disponibilità a “dipendere” credo ne sia uno dei fondamenti. 51
Dipendere dalla vita, dalla verità e dal desiderio di verità, dal paziente,
da sé stessi e da quello che si sperimenta, dalla teoria psicoanalitica e
dallo spirito critico che la mette in discussione. La “buona dipendenza”
– che è vicina a un’idea di permeabilità e all’esperienza dell’affidarsi, ed
è agli antipodi della sottomissione, del bisogno drogato, del
compiacimento masochista – rende possibile dipendere anche da un
oggetto cattivo mantenendo un’autonomia di pensiero e di reazione,
senza troppa angoscia o manovre protettive. Il paziente – in una certa
misura e in qualche momento forse ogni paziente – con i suoi aspetti
distruttivi, il suo essere così diverso da come l’analista se lo
aspetterebbe, o gli farebbe comodo che fosse, può essere vissuto come
un oggetto cattivo. “Dipendere” in modo libero da questo paziente
aiuta a identificarsi reversibilmente con i suoi oggetti e a non essere
dominato – in maniera indistricabile – dalle sue proiezioni. Quando
l’analista ci riesce, si rende conto di quanto l’avvicinarsi sia reso
possibile dalla propria (relativa) “forza” e quanto questa sia cosa
diversa dal “potere” a cui egli stesso può aver fatto ricorso in altri
momenti: un approccio, quest’ultimo, connotato da un certo senso di
superiorità, magari espresso in forme “impeccabilmente’’
psicoanalitiche, in versione “dura’’ (la verità come implacabilità) o
“soffice’’ (l’accoglimento come seduzione).
L’analista è in una situazione più favorevole se i suoi problemi e
difficoltà – che comunque esistono – non si impastano con la sua
struttura caratteriale in un amalgama confuso, perché questo porta
all’agire più che all’affrontare.
Intimità, verità: converge qui tanta parte dell’impegno dell’analista e del
suo modo di essere e di evolvere. Ma anche tanta parte della
psicoanalisi, dei suoi contenuti e della sua storia. Proprio la storia stessa
della psicoanalisi potrebbe essere anche vista come collegata alle
vicissitudini personali – individuali o gruppali – di ampliamento o
restringimento di questa esperienza, un’esperienza di vicinanza. Un
modo di renderla teoria, realtà comunicabile e discorso oggettivato,
Dipendere dalla vita, dalla verità e dal desiderio di verità, dal paziente,
da sé stessi e da quello che si sperimenta, dalla teoria psicoanalitica e
dallo spirito critico che la mette in discussione. La “buona dipendenza”
– che è vicina a un’idea di permeabilità e all’esperienza dell’affidarsi, ed
è agli antipodi della sottomissione, del bisogno drogato, del
compiacimento masochista – rende possibile dipendere anche da un
oggetto cattivo mantenendo un’autonomia di pensiero e di reazione,
senza troppa angoscia o manovre protettive. Il paziente – in una certa
misura e in qualche momento forse ogni paziente – con i suoi aspetti
distruttivi, il suo essere così diverso da come l’analista se lo
aspetterebbe, o gli farebbe comodo che fosse, può essere vissuto come
un oggetto cattivo. “Dipendere” in modo libero da questo paziente
aiuta a identificarsi reversibilmente con i suoi oggetti e a non essere
dominato – in maniera indistricabile – dalle sue proiezioni. Quando
l’analista ci riesce, si rende conto di quanto l’avvicinarsi sia reso
possibile dalla propria (relativa) “forza” e quanto questa sia cosa
diversa dal “potere” a cui egli stesso può aver fatto ricorso in altri
momenti: un approccio, quest’ultimo, connotato da un certo senso di
superiorità, magari espresso in forme “impeccabilmente’’
psicoanalitiche, in versione “dura’’ (la verità come implacabilità) o
“soffice’’ (l’accoglimento come seduzione).
L’analista è in una situazione più favorevole se i suoi problemi e
difficoltà – che comunque esistono – non si impastano con la sua
struttura caratteriale in un amalgama confuso, perché questo porta
all’agire più che all’affrontare.
Intimità, verità: converge qui tanta parte dell’impegno dell’analista e del
suo modo di essere e di evolvere. Ma anche tanta parte della
psicoanalisi, dei suoi contenuti e della sua storia. Proprio la storia stessa
della psicoanalisi potrebbe essere anche vista come collegata alle
vicissitudini personali – individuali o gruppali – di ampliamento o
restringimento di questa esperienza, un’esperienza di vicinanza. Un
modo di renderla teoria, realtà comunicabile e discorso oggettivato,