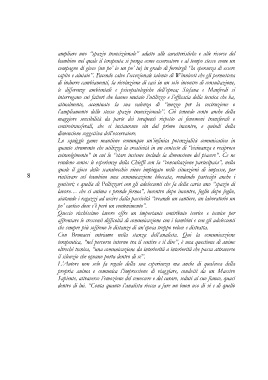Page 7 - Il vaso di Pandora XXII n.2 2014
P. 7
ampliare uno “spazio transizionale” adatto alle caratteristiche e alle risorse del
bambino nel quale il terapeuta si ponga come osservatore e al tempo stesso come un
compagno di gioco (un po’ io un po’ tu) in grado di fornirgli “la speranza di essere
capito e aiutato”. Facendo salvo l’eccezionale talento di Winnicott che gli permetteva
di indurre cambiamenti, la risoluzione di casi in un solo incontro di consultazione,
le differenze ambientali e psicopatologiche dell’epoca; Stefana e Manfredi si
interrogano sui fattori che hanno mutato l’utilizzo e l’efficacia della tecnica che ha,
attualmente, accentuato la sua valenza di “mezzo per la costruzione o
l’ampliamento dello stesso spazio transizionale”. Ciò tenendo conto anche della
maggiore sensibilità da parte dei terapeuti rispetto ai fenomeni transferali e
controtransferali, che si instaurano sin dal primo incontro, e quindi della
dimensione soggettiva dell’osservatore.
Lo squiggle game mantiene comunque un’infinita potenzialità comunicativa in
quanto strumento che utilizza la creatività in un contesto di “vicinanza e reciproco
coinvolgimento” in cui lo “stare insieme include la dimensione del piacere”. Ce ne
rendono conto: le esperienze della Chieffi con la “consultazione partecipata”, nella
quale il gioco dello scarabocchio viene impiegato nelle situazioni di impasse, per
8 riattivare col bambino una comunicazione bloccata, rendendo partecipi anche i
genitori; e quella di Pellizzari con gli adolescenti che fa della carta uno “spazio di
lavoro… che si anima e prende forma”, incontro dopo incontro, foglio dopo foglio,
aiutando i ragazzi ad uscire dalla passività “creando un cantiere, un laboratorio un
po’ caotico dove c’è però un contenimento”.
Questo ricchissimo lavoro offre un importante contributo teorico e tecnico per
affrontare le crescenti difficoltà di comunicazione con i bambini e con gli adolescenti
che sempre più soffrono le distanze di un’epoca troppo veloce e distratta.
Con Brunacci entriamo nella stanza dell’analista. Qui la comunicazione
terapeutica, “nel percorso interno tra il sentire e il dire”, è una questione di anime
oltreché tecnica, “una comunicazione da interiorità a interiorità che passa attraverso
il silenzio che ognuno porta dentro di sé”.
L’Autore non solo fa regalo della sua esperienza ma anche di qualcosa della
propria anima e comunica l’impressione di viaggiare, condotti da un Maestro
Sapiente, attraverso l’emozione del conoscere e del curare, seduti al suo fianco, quasi
dentro di lui. “Conta quanto l’analista riesca a fare un buon uso di sé e di quello
bambino nel quale il terapeuta si ponga come osservatore e al tempo stesso come un
compagno di gioco (un po’ io un po’ tu) in grado di fornirgli “la speranza di essere
capito e aiutato”. Facendo salvo l’eccezionale talento di Winnicott che gli permetteva
di indurre cambiamenti, la risoluzione di casi in un solo incontro di consultazione,
le differenze ambientali e psicopatologiche dell’epoca; Stefana e Manfredi si
interrogano sui fattori che hanno mutato l’utilizzo e l’efficacia della tecnica che ha,
attualmente, accentuato la sua valenza di “mezzo per la costruzione o
l’ampliamento dello stesso spazio transizionale”. Ciò tenendo conto anche della
maggiore sensibilità da parte dei terapeuti rispetto ai fenomeni transferali e
controtransferali, che si instaurano sin dal primo incontro, e quindi della
dimensione soggettiva dell’osservatore.
Lo squiggle game mantiene comunque un’infinita potenzialità comunicativa in
quanto strumento che utilizza la creatività in un contesto di “vicinanza e reciproco
coinvolgimento” in cui lo “stare insieme include la dimensione del piacere”. Ce ne
rendono conto: le esperienze della Chieffi con la “consultazione partecipata”, nella
quale il gioco dello scarabocchio viene impiegato nelle situazioni di impasse, per
8 riattivare col bambino una comunicazione bloccata, rendendo partecipi anche i
genitori; e quella di Pellizzari con gli adolescenti che fa della carta uno “spazio di
lavoro… che si anima e prende forma”, incontro dopo incontro, foglio dopo foglio,
aiutando i ragazzi ad uscire dalla passività “creando un cantiere, un laboratorio un
po’ caotico dove c’è però un contenimento”.
Questo ricchissimo lavoro offre un importante contributo teorico e tecnico per
affrontare le crescenti difficoltà di comunicazione con i bambini e con gli adolescenti
che sempre più soffrono le distanze di un’epoca troppo veloce e distratta.
Con Brunacci entriamo nella stanza dell’analista. Qui la comunicazione
terapeutica, “nel percorso interno tra il sentire e il dire”, è una questione di anime
oltreché tecnica, “una comunicazione da interiorità a interiorità che passa attraverso
il silenzio che ognuno porta dentro di sé”.
L’Autore non solo fa regalo della sua esperienza ma anche di qualcosa della
propria anima e comunica l’impressione di viaggiare, condotti da un Maestro
Sapiente, attraverso l’emozione del conoscere e del curare, seduti al suo fianco, quasi
dentro di lui. “Conta quanto l’analista riesca a fare un buon uso di sé e di quello